Il cuore è un muscolo cavo del tutto particolare, che svolge il fondamentale ruolo di pompare continuamente il sangue attraverso il corpo.
Nell’arco di 24 ore, nel cuore passano circa 4000 litri di sangue; in settant’anni di vita, in media, il nostro cuore si contrae e si rilassa 2 miliardi e mezzo di volte pompando i circa 5 litri e mezzo di sangue del nostro corpo attraverso quasi 96000 km di vasi sanguigni…
La sua struttura è perfetta per questa funzione: il tessuto cardiaco ha aspetti tipici del tessuto muscolare sia striato che liscio, una particolarità che garantisce questa costante, perdurante e faticosa attività.
Posto al centro di un circuito a forma di 8, il cuore è funzionalmente e strutturalmente
compartimentato in modo da costituire una doppia pompa: la metà sinistra spinge il sangue ossigenato proveniente dalle vene polmonari dentro l’aorta e verso tutto il corpo; la metà destra spinge il sangue povero di ossigeno che affluisce dalle vene cave dentro le arterie polmonari e verso i polmoni.
Ciascuna metà del cuore è suddivisa in 2 camere: quella più in alto è detta atrio o orecchietta, e funge da punto di raccolta del sangue in afflusso; quella più in basso è detta ventricolo, e si contrae con forza infondendo al sangue la spinta necessaria a seguire, di volta in volta, la circolazione generale o quella polmonare. Poiché la circolazione generale è molto più sviluppata di quella polmonare, il ventricolo sinistro ha una massa muscolare maggiore: è la sua contrazione che imprime il battito apicale a tutto il cuore. Da ciascun ventricolo si diparte un’arteria, il cui accesso è regolato da una valvola semilunare che impedisce il reflusso del sangue.
Le due metà cardicache (destra e sinistra) sono separate da un setto che in alto prende il nome di setto interatriale e in basso è detto setto interventricolare. Atrio e ventricolo, poi, sono separati da una valvola atrioventricolare: un setto membranoso ancorato a cordoni tendinei non elastici che lo mantengono in posizione e che si diramano da muscoli papillari, costituiti da un’estensione delle pareti del ventricolo. Al momento della contrazione del ventricolo, anche i muscoli papillari si contraggono provocando la chiusura delle valvole e impedendo il reflusso del sangue da una camera all’altra.
IL CICLO CARDIACO
È detta così la successione di eventi che si ripete nel cuore e che ne caratterizza l’attività.
A ogni battito corrisponde una successione di fasi di contrazione (sistole) o di rilassamento (diastole) delle quattro parti del muscolo cardiaco secondo una precisa sequenza:
1-gli atri, rilassati, si riempiono di sangue;
2-la pressione dentro gli atri aumenta, man mano che essi si riempiono; questo provoca l’apertura delle valvole atrioventricolari;
3-gli atri si contraggono, determinando l’immediato riempimento dei ventricoli;
4-anche i ventricoli iniziano a contrarsi: ciò determina la chiusura delle valvole atrio-ventricolari;
5-la pressione all’interno dei ventricoli sale notevolmente al di sopra della pressione sanguigna esistente nelle arterie;
6-ciò fa aprire le valvole semilunari: il sangue fuoriesce dai ventricoli che si svuotano, rilassandosi, e scorre nelle arterie;
7-gli atri, già rilassati, si stanno riempiendo nuovamente di sangue: e il ciclo continua.
La contrazione delle cellule muscolari cardiache è spontanea: anche se si interrompono tutti i nervi che raggiungono il cuore, esso continua a contrarsi!
La contrazione coordinata e progressiva di tutte le cellule viene regolata dal nodo senoatriale, un gruppo di cellule cardiache poste nella zona superiore del –
latrio destro che “danno inizio” al ciclo cardiaco. Esse producono un “onda di eccitazione” che si propaga in entrambi gli atri provocandone la contrazione simultanea; una volta raggiunto il nodo atrioventricolare, un gruppo di cellule del pavimento dell’atrio destro, essa si smorza in modo da consentire agli atri di contrarsi completamente prima che inizino a contrarsi i ventricoli.
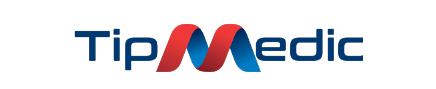

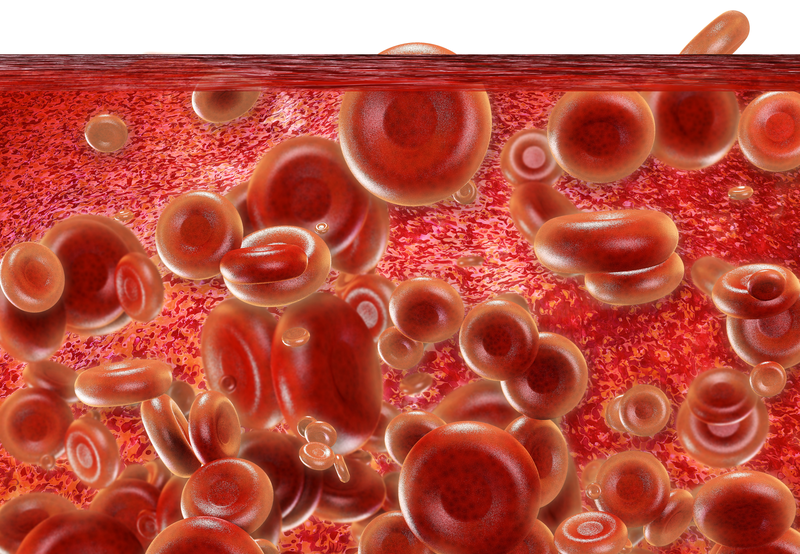
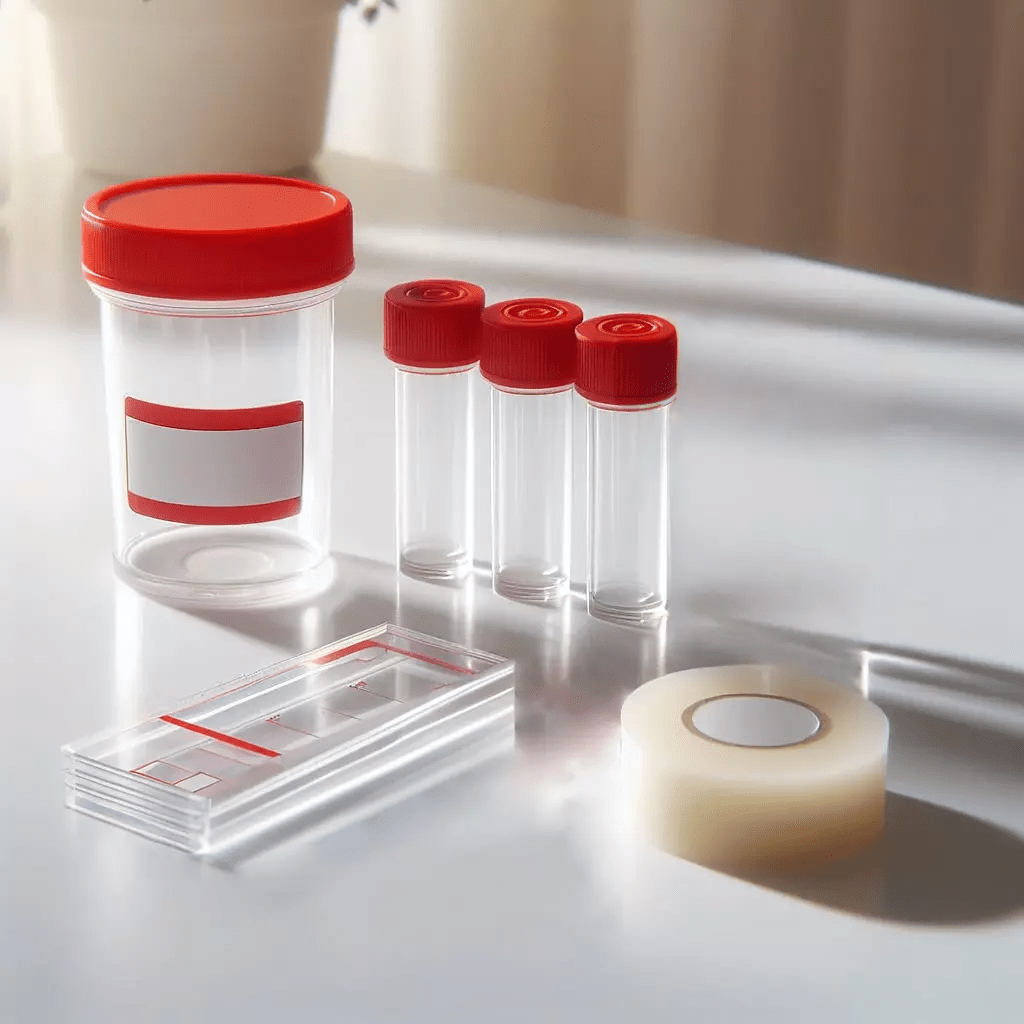


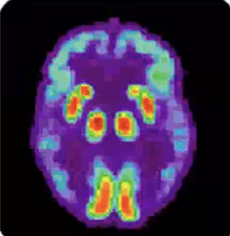
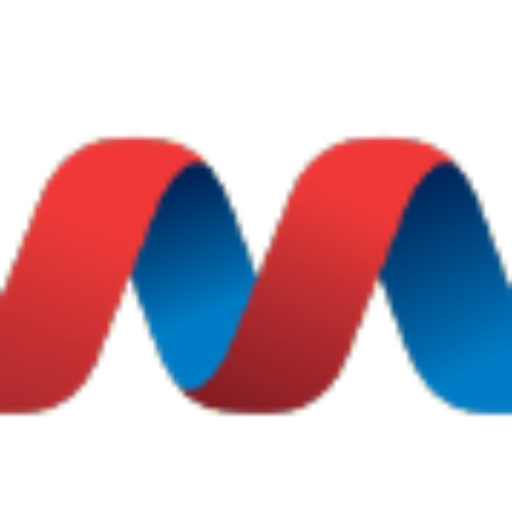
0 commenti